Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Contro gli stereotipi: lavoro, stigma e diritti delle persone migranti
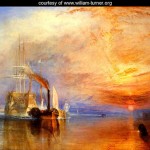
The Fighting ‘Téméraire’ tugged to her last Berth to be broken up – William Turner
In Italia, quando si parla di persone straniere, il dibattito pubblico è spesso dominato da stereotipi e slogan ripetitivi: “rubano il lavoro agli italiani”, “non pagano le tasse”, “pesano sul welfare”. Queste frasi, largamente diffuse, non solo non corrispondono ai dati reali, ma alimentano diffidenza, intolleranza e discriminazione.
È proprio per decostruire questi luoghi comuni che nasce il nostro progetto di ricerca, condotto da antropologi e psicologi presso la CGIL Stranieri di Bologna, in ascolto diretto delle esperienze lavorative e personali delle persone migranti. La ricerca che si avvierà dal mese di settembre verrà svolta dalle psicologhe che collaborano con l’associazione Valore Lavoro e dai prof. Luca Jourdan e Valerio Romitelli del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.
Il lavoro non è solo una fonte di reddito: è anche un luogo simbolico e sociale, dove si costruiscono relazioni, dignità, appartenenza. Per chi arriva in Italia da altri Paesi, lavorare significa spesso affrontare un doppio sguardo: quello della società ospitante e quello su di sé, dentro un sistema che raramente riconosce il valore delle competenze portate con sé.
In un contesto economico neoliberale, dove il valore delle persone è misurato in produttività, chi vive condizioni di precarietà rischia di essere etichettato come “inadeguato”, “non abbastanza bravo”, “da colpevolizzare”.
In psicologia, lo stigma è un processo attraverso cui una persona viene ridotta a una sola caratteristica, considerata negativa o deviante. Per il sociologo Erving Goffman, che ha approfondito questa dinamica relazionale, lo stigma è una forma di “identità svalutata” che porta isolamento, vergogna e esclusione.
Secondo Link e Phelan (2001), lo stigma si costruisce in quattro passaggi: etichettare una persona come “diversa”, attribuirle stereotipi negativi, separarla dal gruppo sociale e infine legittimare discriminazioni e disuguaglianze.
Chi subisce stigma – come molte persone migranti – sperimenta più facilmente disagio psicologico, bassa autostima, ansia sociale e maggiore rischio di isolamento. Questi effetti sono ampiamente confermati dalla letteratura della psicologia transculturale, in particolare dagli studi di Marie Rose Moro. Moro sottolinea come le esperienze migratorie siano marcate da una tensione identitaria tra appartenenze multiple e da un’esposizione significativa alla vulnerabilità psichica, legata sia a traumi pregressi che a discriminazioni vissute nei contesti di accoglienza.
Marie Rose Moro e altri studiosi della psicologia transculturale insistono sull’importanza di uno sguardo capace di accogliere l’altro nella sua complessità culturale, e di pratiche che valorizzino la narrazione, il racconto di sé, come strumento di cura e riconoscimento. Lo stigma agisce nel senso opposto: impedisce la narrazione, congela le possibilità di essere ascoltati e riconosciuti.
Gli studi più recenti confermano che il 38% dei lavoratori migranti si sente escluso nel contesto lavorativo (EU-Migrant Workers Survey, 2021), il 52% non si sente ascoltato quando manifesta un disagio psicologico e che le donne migranti nel lavoro di cura sono tra le più esposte a sindromi da stress, solitudine e burnout (ILO, 2023).
Come psicologi e psicoterapeuti, ci siamo spesso orientati verso la comprensione dei fattori individuali che generano disagio. Tuttavia, già da tempo abbiamo iniziato a volgere lo sguardo anche verso quei fattori esterni e ambientali — sociali, economici, culturali — che producono sofferenza psichica.
Sempre più spesso incontriamo persone che non stanno male a causa di un conflitto intrapsichico o di una fragilità personale, ma perché vivono in un sistema che rende la vita instabile, faticosa, non riconosciuta. Non sto male perché ho un problema “mio”, ma perché la società in cui vivo genera esclusione, precarietà, invisibilità. È un malessere che ha radici sociali, che parla della relazione tra l’individuo e il mondo.
CHI SIAMO:
Nel 2017 psicologi e antropologi diedero vita a PAD, un progetto di assistenza alla disoccupazione. Siamo tornati in un luogo dove la questione del lavoro è centrale e quotidiana: la CGIL. Nella precedente edizione del progetto PAD, il nostro gruppo ha condotto una ricerca approfondita sui disoccupati e sui lavoratori precari. Ora, in questa nuova fase, rivolgiamo la nostra attenzione alle persone straniere che lavorano nel nostro paese.
Il progetto di oggi, come quello di allora, poggia su un approccio multidisciplinare ed integrato. Riconosciamo che il disagio psicologico non può essere compreso appieno se non tenendo conto delle condizioni socioeconomiche e dei contesti di esclusione in cui le persone migranti vivono.
Ora, il nuovo progetto si propone di indagare, attraverso un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, come le persone straniere si trovino nel contesto italiano, sia nella vita quotidiana che nel mondo del lavoro. Non si parte dall’assunto che questa popolazione sia fragile, ma dall’ascolto attento e dal desiderio di comprendere direttamente dalle loro parole quali sono le condizioni reali in cui vivono, quali sfide affrontano, ma anche quali risorse e strategie sono in campo.
Gli psicologi approfondiranno gli aspetti emotivi, relazionali e affettivi del vissuto lavorativo e migratorio. Gli antropologi si focalizzeranno su cosa gli intervistati dicono e pensano dell’esperienza lavorativa in atto, del loro rapporto con lo sportello CGIL e più in generale del contesto in cui si trovano a vivere: il tutto con l’obiettivo di valorizzare enunciati e opinioni spesso trascurate o inascoltate.
Il progetto si configura come una ricerca in cui teoria e pratica si intrecciano, con l’obiettivo di fornire conoscenze utili e concrete a chi governa e prende decisioni, affinché le politiche sociali e del lavoro possano essere più sensibili e rispondenti ai bisogni reali.
– ISTAT (2023). Occupati e disoccupati in Italia.
– INPS (2023). Rapporto annuale sulla contribuzione straniera.
– Link, B.G., & Phelan, J.C. (2001). Conceptualizing stigma.
– Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity.
– ILO (2023). Care work and migration.
– CGIL-Salute (2022). Accesso ai servizi di salute mentale per i migranti.
– Moro, M.R. (2002). Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent: une approche transculturelle.
– Moro, M.R. (2018). La construction identitaire des enfants de l’immigration. Paris: La Découverte.






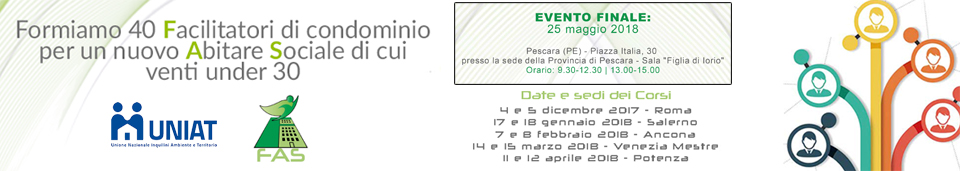
1 Responses to Contro gli stereotipi: lavoro, stigma e diritti delle persone migranti