Widgetized Section
Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Capitalismo e distruzione
Il capitalismo dell’ultimo mezzo secolo ha tratto vigore dai vantaggi offerti dalla libera e crescente circolazione di merci e capitali, accompagnata dallo sviluppo dell’innovazione e da politiche neoliberiste favorite dall’attività di organismi multilaterali quale il WTO[1].
I pregevoli effetti di valore culturale e sociale insiti nella caduta di barriere tra i paesi si sono rivelati vieppiù vantaggiosi sul piano economico. Il basso costo della manodopera, la carente tutela del lavoro e dell’ambiente nei paesi emergenti hanno consentito ampi margini di guadagno alle economie avanzate.
Il grafico dimostra la rapida crescita del commercio mondiale in mezzo secolo.
fonte: WTO import export e saldi dati riassuntivi 1961-2015 (valori in migliaia euro correnti)
La globalizzazione ha trovato fondamento nei vantaggi comparati[2] nella produzione di beni che offrivano ampi margini economici.
Con il tempo in realtà ha rivelato limiti:
- nella capacità della domanda di assorbire un offerta illimitata di merci per la progressiva saturazione dei mercati
- uno sviluppo della logistica impattante sull’ambiente
- la de-industrializzazione dei paesi avanzati a seguito del processo di de-localizzazione.
- problemi occupazionali
Si è creato un crescente divario tra economia reale e finanziaria.
Nelle economie avanzate, a fronte di una aumentata accumulazione e concentrazione di capitali e formazione di conglomerati tecno-finanziari (turbo capitalismo), si è verificato un deterioramento della posizione commerciale e un forte indebitamento dello stato e dei privati. Particolarmente evidente l’indebitamento pubblico e privato statunitense.
L’attuale fase storica del capitalismo sembra riscoprire l’economia reale, fatta di terre (rare o meno), merci, fabbriche, manodopera in realtà è ancora la finanza, in specie quella speculativa, a guidare le scelte del capitale (v. sviluppo criptovalute).
Il multilateralismo, la cooperazione internazionale, vengono sostituiti da rapporti di forza bilaterali. Il giocare alla pari (level playing field), è sostituito da rapporti di forza neocolonialisti. La “libertà economica” di Clinton diviene l’autocrazia di Trump.
La storia ci insegna che Il capitalismo tende a rigenerarsi a prescindere dagli effetti diretti o indiretti sui fattori sociali. E’ ciò che sta succedendo. Il mercato non sembra più capace di autoregolarsi, come sostenevano illusoriamente i neoliberisti, ma deve essere “protetto”. Se l’economia genera ricchezza solo per pochi e il debito interno, come negli USA, raggiunge vette pericolose, si pensa che una aggressiva politica di dazi posa diventare la panacea per risanare la posizione debitoria nazionale.
La minaccia neo-protezionista trumpiana, rivela come fossero errate le previsioni americane dei primi anni 2000. L’intento di trasformare la Cina in un mercato libero in realtà ha trasformato/impoverito le economie occidentali.
Nei paesi occidentali si riaffaccia lo spettro della stagflazione, recessione accompagnata da inflazione. Una condizione che tra l’altro rende gli strumenti di politica monetaria un’arma spuntata e il dollaro rischia di perdere la funzione di moneta di riferimento negli scambi internazionali.
Il meccanismo globale si è inceppato come dimostra la contrazione del commercio mondiale. Cina e India continuano a crescere a ritmi consistenti mentre in Occidente si assiste ad un calo della produzione e del grado di fiducia delle aziende che assume caratteri strutturali.
Il vero problema è che l’attuale modello di economia capitalistica stenta a perpetuarsi per la insostenibilità (umana ed ambientale) del processo di accumulazione fondato sulla illimitata produzione di merci a mezzo merci e sulla capacità del mercato di assorbire tale produzione.
La recessione viene spesso letta come un evento ciclico “naturale” che colpisce la nostra società sul quale abbiamo limitate possibilità di intervento sia come individui che collettività. In realtà la “naturalità” della recessione è generata dalla macchina capitalistica che gira a vuoto. Da qui discende una emotività collettiva di impotenza e di sfiducia nel futuro.
I crescenti conflitti internazionali e il clima di paura circa ipotetiche invasioni dall’ Est Europa indicano la “sicurezza”, nelle sue varie declinazioni, quale vettore ciclico virtuoso dell’economia, dove il settore degli armamenti gioca un ruolo fondamentale. Ciò alimenta la crescente disparità tra paesi tecnologicamente e militarmente avanzati e paesi costretti a investire in armamenti a discapito della spesa per il welfare.
La distruzione di oggi, effetto dell’uso insensato della guerra, non è quella creativa teorizzata da Shumpeter fondata sull’innovazione e il ciclo economico[3], ma nasce dal circuito vizioso per il quale la distruzione materiale rigenera l’economia.
In realtà questo nuovo cortocircuito capitalistico può essere l’occasione per rivedere il nostro modello di sviluppo.
Tenuto conto che abbiamo risorse naturali limitate e l’ambiente naturale e sociale mostra evidenti segni di cedimento occorre leggere, culturalmente e materialmente, la minore crescita non come una calamità o il ritorno alla arretratezza del passato ma come un processo responsabile nel quale siamo attori del futuro.
Per incidere sul modello di sviluppo occorre innanzitutto rivedere uno dei fondamenti dell’economia di mercato: il concetto di domanda ed offerta di beni e servizi finalizzato alla determinazione del prezzo di mercato.
In realtà bisogna osservare i due fattori di prezzo da un altro punto di osservazione.
Dal lato dell’offerta la logica capitalistica è da sempre quella di massimizzare il profitto facendo leva sulle quantità e sui vantaggi comparati. Le economie di scala o il superamento di soglie critiche di produzione generano beni e servizi in eccesso rispetto alla capacità di assorbimento del mercato. La politica del “discount” della grande distribuzione e l’azione “pornografica”[4] della pubblicità drogano il mercato con il risultato reale di sprechi e diseconomie. La minore crescita è vista indubbiamente come una condizione penalizzante.
La prospettiva di cambiamento può nascere dal lato della domanda: il consumo responsabile può essere la leva generativa di una decrescita, basata su una visione sostenibile e condivisa della realtà.
La decrescita felice[5] fa leva su dinamiche riferibili al bene comune: si alimenta di economie circolari, promuove relazioni generative, attiva la socialità. Il consumo si trasforma in una pratica felice se fondato sulla relazione umana, se facilita e permette il riconoscimento sociale senza peraltro costituirne l’unica chiave identitaria e nemmeno la più importante.
Luciano Fiordoni
Sovicille
28 luglio 2025
- [1] Grazie all’apertura americana del presidente Clinton nel 2001 la Cina entrava nell’organizzazione mondiale del commercio. Secondo Clinton «Pechino importerà uno dei valori più importanti della democrazia: la libertà economica».
[2] il costo-opportunità della produzione di un bene in termini di altri beni è minore in un paese rispetto agli altri competitors
[3] descrive il processo di sviluppo capitalistico come un flusso continuo di innovazione, in cui nuove tecnologie e modelli di business spazzano via quelli vecchi. Questo processo, sebbene causi la scomparsa di aziende e posti di lavoro, è considerato essenziale per la crescita economica a lungo termine.
[4] Trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetti o immagini, fatta con lo scopo di stimolare il consumo
[5] Nel 2008 l’economista Serge Latouche usciva con un libro che teorizzava la decrescita felice o serena[5]. Tale ipotesi risultava provocatoria in un periodo di forte turbolenza economica internazionale e preconizzava la crisi del modello capitalistico di oggi.






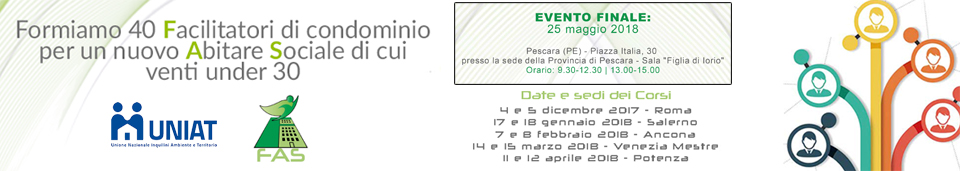
3 Responses to Capitalismo e distruzione